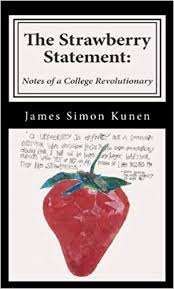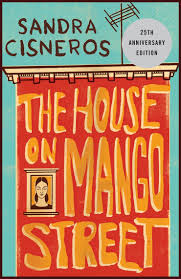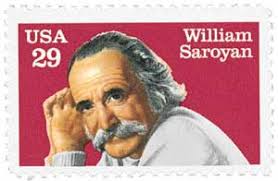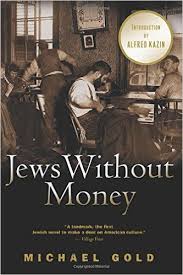Grandissima raccolta di racconti di Denis Johnson, magistralmente tradotta da Silvia Pareschi. Bar e motel squallidi, periferie cupe e anonime animate da personaggi alterati da alcol e droghe, ma comunque sempre umani. Veramente bellissimo.

INCIDENTE DURANTE L’AUTOSTOP
[…]Lungo il corridoio avanzava la moglie. Era magnifica, ardente. Non sapeva ancora che suo marito era morto. Noi invece si. Ecco cosa le dava tanto potere su di noi. Il medico l’ha portata in una stanza con una scrivania in fondo al corridoio, e da sotto la porta chiusa si è sprigionata una lastra di fulgore, come se, grazie a qualche stupefacente processo, lì dentro stessero incenerendo dei diamanti. Che polmoni! Strillava come avrebbe potuto strillare un’aquila. Che meraviglia essere vivo per poterla sentire! Da allora non ho più smesso di cercare quella sensazione.
“Sto bene”: mi sorprendo di aver pronunciato quelle parole. Ma ho sempre avuto la tendenza a mentire ai dottori, come se la salute consistesse solo nella capacità di ingannarli.
Qualche anno dopo, una volta che mi avevano ricoverato nel reparto di disintossicazione del Seattle General Hospital, ho seguito lo stesso approccio.
– Sente voci e rumori insoliti?- mi ha chiesto il medico.
-Aiutaci, oddio, che dolore,- urlavano le scatole del cotone.
-Non proprio,- ho detto.
-Non proprio,- ha ripetuto il medico. -E cosa vuol dire?
-Non sono pronto a parlarne,- ho risposto. Un uccello giallo mi ha svolazzato vicino alla faccia, e i miei muscoli si sono contratti. Ora mi dibattevo con un pesce. Quando ho strizzato gli occhi, lacrime bollenti mi sono esplose fuori dalle orbite. Quando li ho aperti, ero girato a pancia in giù.
-Come mai la camera è diventata così bianca?- ho chiesto.
Una bella infermiera mi stava sfiorando la pelle. -Queste sono vitamine,- ha detto mentre infilava l’ago.
Stava piovendo. Felci gigantesche pendevano su di noi. La foresta digradava giù per una collina. Sentivo un torrente correre tra le rocce. E voi, gente ridicola, voi aspettate che io vi aiuti.
FUORI SU CAUZIONE
Jack Hotel beveva accanto a me, riflesso nello specchio.
C’erano altri identici a noi, e questo ci consolava.
Cosa non darei, certe volte, per un altro incontro come quello, noi due seduti in un bar alle nove del mattino a raccontarci bugie, dimentichi di Dio.
Anche Hotel aveva litigato con la sua ragazza. Aveva vagato per le strade come me. Abbiamo bevuto di pari passo finché non abbiamo finiti soldi.
Sapevo di un condominio dove arrivavano ancora gli assegni della pensione di un inquilino morto. Li rubavo regolarmente da sei mesi, sempre con trepidazione, sempre aspettando un paio di giorni dopo il loro arrivo, sempre pensando che avrei trovato una maniera onesta di guadagnare qualche dollaro, sempre considerandomi una persona perbene che non avrebbe dovuto fare certe cose, sempre esitando perché temevo che stavolta mi avrebbero beccato.
[…] Con quei soldi abbiamo comprato dell’eroina e ce la siamo divisa in parti uguali.
Poi lui è andato a cercare la sua ragazza, e io sono andato a cercare la mia, sapendo che quando c’era di mezzo la droga capitolava.
Ma ero in cattive condizioni, ubriaco e reduce da una notte insonne. Appena la roba mi è entrata in circolo, ho perso i sensi. Sono passate due ore senza che me ne accorgessi.
Credevo di avere appena chiuso gli occhi, ma quando li ho riaperti la mia ragazza e un vicino messicano stavano lavorando su di me, facendo tutto il possibile per riportarmi indietro. Il messicano stava dicendo: – eccolo che si sveglia.
Abitavamo in un appartamentino sudicio. Quando capito che era rimasto svenuto a lungo e avevo rischiapassate due ore senza che me ne accorgessi. Credevo di aver appena chiuso gli occhi, ma quando gli ho riaperti la mia ragazza è un vicino messicano stavano lavorando su di me, facendo tutto il possibile per riportarmi indietro. Il messicana stava dicendo: eccolo che si sveglia.
Abitavamo in un appartamentino sudicio. Quando ho capito che ero rimasto svenuto a lungo e avevo rischiato di andarmene per sempre, mi è sembrato che la nostra casetta luccicasse come bigiotteria. Ero contentissimo di non essere morto. Di solito, se proprio mi veniva da riflettere sul senso della vita, al massimo arrivavo a considerarmi la vittima di uno scherzo. Nessun contatto con l’orlo del mistero, nessun istante in cui qualcuno di noi – be’, parlo solo per me, immagino – si sentiva i polmoni pieni di luce o roba del genere. Eppure quella notte ho vissuto un momento di gloria. Ero sicuro di essere qui, in questo mondo, perché non potevo tollerare nessun altro posto.
Quanto a Hotel, che era nelle mie stesse identiche condizioni e aveva dietro la stessa quantità di eroina, ma non avevo dovuto a spartirla con la sua ragazza perché quel giorno non era riuscito a trovarla: ha raggiunto una pensione in fondo a Iowa Avenue ed è andato anche lui in overdose. E’ entrato in un sonno profondo e all’inizio la gente che era lì l’ha preso per morto.
Ogni tanto quelli che erano con lui, tutti i nostri amici, gli controllavano il respiro mettendogli uno specchietto sotto le narici e verificando che si appannasse. Ma dopo un po’ si sono dimenticati di lui, e Hotel ha smesso di respirare senza che nessuno se ne accorgesse. Si è spento. È morto.
Io sono ancora vivo.
DUNDUN
Dundon ha torturato Jack Hotel sul lago vicino a Denver. L’ha fatto per ottenere informazioni su un oggetto rubato, uno stereo che apparteneva la sua ragazza, o forse a sua sorella. In seguito, Dundun ha quasi ammazzato un uomo con un aggeggio per cambiare le gomme in una strada di Austin, in Texas, e un giorno dovrà rispondere anche di questo, ma adesso si trova, penso, nella prigione di Stato del Colorado. Mi credete se vi dico che in fondo al cuore era buono? La sua mano sinistra non sapeva cosa faceva la destra. È solo che certi importanti collegamenti erano bruciati. Se vi aprissi la testa e vi passassi una saldatrice e sul cervello, potreste diventare così anche voi.
MATRIMONIO SPORCO
Mi piaceva sedermi davanti e viaggiare su quelli veloci per tutto il giorno, mi piaceva quando sfioravano gli edifici a nord del Loop e soprattutto mi piaceva quando, un po’ più a nord, gli edifici sparivano in quello squallore da bombardamento dove la gente (dietro le finestre vedevi qualcuno che si portava alla bocca una cucchiaiata di minestra in una cucina sudicia e spoglia, o dodici bambini sdraiati pancia a terra a guardare la televisione, ma un istante dopo erano spariti, spazzati via dal cartellone di un film con una donna che strizzava l’occhio e si toccava abilmente il labbro superiore con la punta della lingua, a sua volta cancellata da una – sbam, il rumore e il buio ti piombavano intorno alla testa – galleria) viveva per davvero.
Avevo venticinque o ventisei anni, qualcosa del genere. I polpastrelli gialli di nicotina. E una ragazza che aspettava un bambino.
Prendere il treno costava cinquanta centesimi, o forse novanta, o un dollaro. Non me lo ricordo proprio.
Davanti al posto dove facevano gli aborti i dimostranti ci spruzzavano addosso l’acqua santa e si rigiravano i rosari intorno alle dita.
[…] Seduta in diagonale rispetto me c’era una dolce ragazzina nera di circa sedici anni, strafatta di ero. Non riusciva a tenere su la testa. Non riusciva a restare fuori dai suoi sogni. Lo sapeva: merda, potevamo pure bere lacrime di cane. Niente aveva importanza, tranne che eravamo vivi.
– Non ho mai assaggiato il miele nero, – le ho detto.
Lei si è grattata il naso e ha chiuso gli occhi, tuffando la faccia nel paradiso.
L’ho chiamata: – Ehi.
– Nero. Io non sono nera, – ha detto. – Sono gialla. Non darmi della nera.
– Vorrei un po’ di quello che hai tu.
– Finita, ragazzo. Finita, finita, finita -. Rideva come Dio. Ma non gliene ho fatto una colpa.
– Dici che se ne può trovare dell’altra?
– Quanta ne vuoi? Ce l’hai un deca?
– Forse. Certo.
– Andiamo, ti ci porto, – ha detto. – Ti porto al Savoy -.
E dopo altre due fermate l’ho seguita giù dal treno in strada. Intorno ai falò accesi nei bidoni della spazzatura c’era gente che borbottava e cantava, quel genere di cosa. Lampioni e semafori avevano protezione di rete metallica.
Alcuni credono che dovunque guardi vedi solo te stesso. Episodi come questo mi fanno pensare che forse è vero.
Il Savoy Hotel era un postaccio. La sua realtà svaniva man mano che si innalzava sopra First Avenue, sicché i piani superiori sgocciolavano via nello spazio. Su per le scale si trascinavano dei mostri. Nel seminterrato c’era un bar che occupava tre lati di un rettangolo, grande come una piscina olimpionica, e un palcoscenico sormontato da un pesante sipario dorato che non si muoveva mai. Tutti sapevano cosa fare. La gente pagava con le banconote fatte strappando l’angolo di un biglietto da venti e appiccicandolo su un biglietto da uno. C’era un uomo con un cappello a cilindro nero, un casco di folti capelli biondi e una barba bionda a punta. Sembrava che volesse stare lì. Come faceva a sapere cosa fare? Le belle donne che scorgevo con la coda dell’occhio sparivano appena mi giravo a guardarle. Inverno fuori. Notte di pomeriggio. Buio, buio all’happy hour. Non conoscevo le regole. Non sapevo cosa fare. L’ultima volta che ero entrato in un Savoy era stato a Omaha. Non mi ci avvicinavo da più di un anno, ma mi sentivo già male. Quando tossivo, vedevo le lucciole.
Tranne il sipario, tutto quanto là sotto era rosso. Sembra un film di qualcosa che stava succedendo davvero. Papponi neri impellicciati. Le donne erano spazi vuoti e scintillanti dentro cui fluttuavano fotografie di ragazze tristi. – Prendo i tuoi soldi e vado sopra, – mi ha detto qualcuno.
[…] Michelle mi ha lasciato definitivamente per uno di nome John Smith, o forse dovrei dire che durante uno dei nostri periodi di separazione si è messa con uno e poi dopo ha avuto un colpo di sfortuna ed è morta? Ad ogni modo, non è mai tornata da me.
[…] Michelle è andata a Kansas City con lui, e una notte, mentre lui era fuori, ha preso un sacco di pillole e gli ha lasciato un biglietto sul cuscino, sicura che l’avrebbe trovato l’avrebbe salvata. Ma quando è tornato era così ubriaco che ha appoggiato la guancia sul biglietto e si è addormentato. Il mattino dopo, quando si è svegliato, la mia bella Michelle era fredda e morta.
Era una donna, una traditrice e un’assassina. Attirava maschi e femmine. Ma io ero l’unico che avrebbe mai potuto amarla.
[…]Il giorno del mio ventiquattresimo compleanno, mentre litigavamo, lei è uscita dalla cucina ed è tornata con una pistola e mi ha sparato cinque volte da un capo all’altro del tavolo. Eppure mi ha mancato. Non voleva la mia vita. Voleva di più. Voleva mangiarmi il cuore e smarrirsi nel deserto con quello che aveva fatto, voleva cadere in ginocchio e partorire così, voleva ferirmi come solo un bambino può essere ferito dalla madre.
Lo so che si discute se sia giusto oppure no, se il bambino si arriva in questa o quella fase del suo sviluppo nel grembo. Ma non era questo il punto. Non era quello che facevano gli avvocati. Non era quello che facevano i medici o quello che faceva la donna. Era quello che la madre e il padre facevano insieme.
HAPPY HOUR
La giornata stava finendo in una gloriosa luce infuocata. Le navi nello stretto sembravano sagome di carta che il sole stava per risucchiare.
Ho bevuto due doppi e subito mi è sembrato di essere sempre stato morto e di essermi finalmente svegliato.
Ero al Pig Alley. Si affacciava direttamente sul porto, costruito sull’acqua sopra un pontile traballante, con i pavimenti di compensato ricoperto di moquette e il banco di formica. Il fumo di sigaretta aveva un aspetto sovrannaturale. Il sole scendeva attraverso il tetto di nuvole, infiammava il mare e riempiva la grande finestra panoramica di luce fusa, così i nostri traffici e i nostri sogni si svolgevano dentro una nebbia radiosa. Chi entrava nei bar di First Avenue abbandonava il proprio corpo. Da quel momento erano visibili solo i demoni che vivevano in noi. Qui venivano riunite le anime che si erano ferite a vicenda. Lo stupratore incontrava la sua vittima, il figlio rifiutato ritrovava sua madre. Ma niente si poteva guarire, lo specchio era un coltello che divideva ogni cosa da se stessa, lacrime di falsa amicizia gocciolavano sul banco. E cosa mi farai adesso? Con cosa, di preciso, intendi spaventarmi?